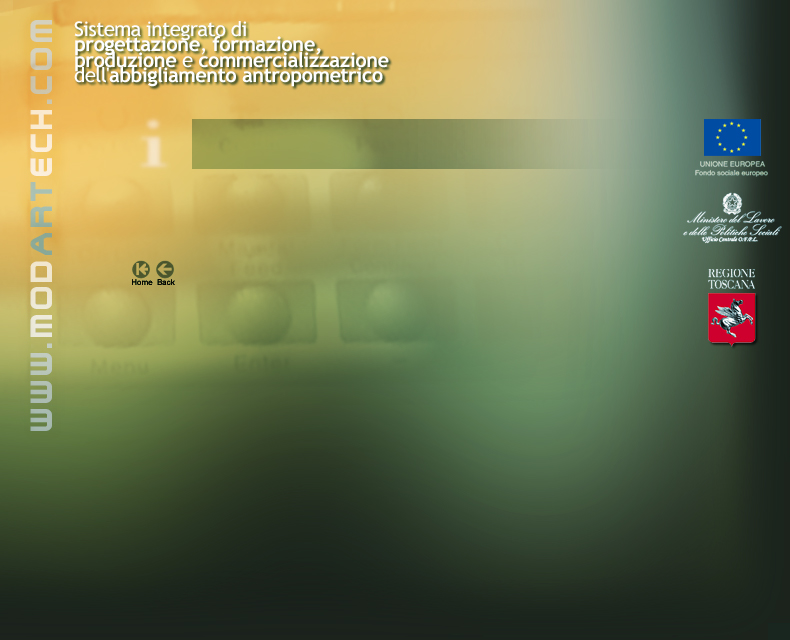
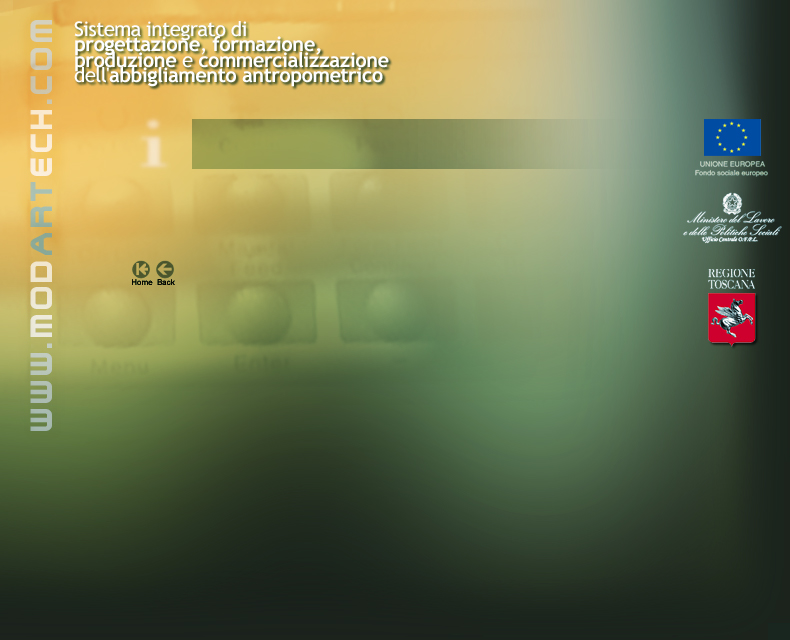 |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|
Nel 1991 in Toscana è localizzato quasi il 20% delle unità locali italiane appartenenti all’industria della moda, per un’occupazione pari a circa 155.000 addetti. Nonostante la Toscana rappresenti comunque una delle regioni italiane in cui è più elevata la specializzazione produttiva nell’industria della moda, la sua posizione relativa rispetto alla Lombardia (altra regione ad elevata specializzazione nel sistema moda) e all’area NEC risulta, all’inizio degli anni Novanta, sensibilmente peggiorata rispetto a quella rilevata nel 1981. Tra il 1991 ed il 1997, sia la Toscana che la Lombardia hanno fatto registrare un’ulteriore diminuzione delle unità locali e degli addetti complessivamente impiegati nel sistema moda.
Un’analisi macro della posizione competitiva relativa del sistema moda toscano può essere fatta solo con riferimento allo scorso decennio a causa della indisponibilità di dati sufficientemente disaggregati ed aggiornati. In particolare, da tale analisi si deduce che, per tutti gli anni Ottanta, il valore aggiunto prodotto dal sistema moda toscano assume un peso costantemente decrescente sia rispetto al corrispondente aggregato dell’industria manifatturiera regionale che rispetto a quello realizzato dall’industria italiana della moda nella sua totalità -a fronte di un costante aumento della quota delle altre regioni dell’area NEC e di una sostanziale stabilità di quella della Lombardia-. Il declino relativo del sistema moda toscano è stato analizzato da vari studiosi sulla base di due distinte ipotesi esplicative che fanno rispettivamente riferimento alla specializzazione produttiva dell’industria manifatturiera locale (Varaldo, Bellini, Bonaccorsi 1997), e ai modelli di impresa prevalenti (Lucchini, Martini 1992; Burresi, 1989; Falorni, Marinari 1992; ORML 1995; Zagnoli 1993; Cavalieri 1995). Nel primo caso, viene enfatizzata l’influenza negativa che, sull’andamento del settore moda, possono aver esercitato: (i) la presenza di imprese marginali, specializzate in produzioni destinate a fasce di mercato medio-basse che hanno subito pesantemente la concorrenza dei Paesi a più basso costo del lavoro; (ii) la scarsa rilevanza, all’interno dell’industria manifatturiera regionale, dei settori produttori di macchine utensili che può aver contribuito a rallentare il necessario processo di innovazione tecnologica all’interno dei comparti del sistema moda. Chi invece sostiene che il declino debba essere imputato ai modelli di impresa prevalenti, sottolinea: a) la forte presenza, in Toscana, di imprese di dimensioni occupazionali “micro” (al di sotto dei 10 addetti) e la contemporanea scarsa rilevanza (rispetto, ad esempio, alla Lombardia, ma anche ad altre regioni dell’area NEC) delle imprese di dimensioni occupazionali medie, in grado di trainare, tramite la costituzione di rapporti “a rete”, lo sviluppo delle imprese minori; b) la scarsa propensione delle imprese locali all’adozione di innovazioni di prodotto e di processo; c) un’insufficiente intensità di capitale nei processi produttivi e una bassa propensione all’attività di investimento che risulta peraltro confermata dai dati ufficiali relativi a tutti gli anni ‘80, periodo in cui la quota degli investimenti del sistema moda toscano sul corrispondente aggregato nazionale decresce sensibilmente, a fronte di una sostanziale stabilità che si registra sia nel caso della Lombardia che delle altre regioni dell’area NEC; d) nella bassa capacità di spostamento mostrata dalle imprese verso funzioni più avanzate e a più elevato valore aggiunto (in linea con i processi di terziarizzazione interna ed esterna dell’industria); e) nella cultura imprenditoriale prevalente che, secondo alcuni autori, risulta addirittura “ostile alla crescita”. I risultati dell’analisi qui svolta, a distanza di qualche anno dagli ultimi dati ufficiali disponibili e presumibilmente a seguito dell’intensificarsi di alcuni fenomeni, quali, ad esempio, quello della concorrenza dei Paesi emergenti, mettono, come vedremo, in risalto elementi che sembrano suggerire la necessità di integrare le due ipotesi interpretative ricordate, finora solitamente trattate come alternative. In Toscana i comparti del sistema moda specializzati nella produzione di beni intermedi, negli ultimi 20 anni, hanno mantenuto il proprio peso relativo rispetto al resto d’Italia, mentre abbigliamento, calzature, maglierie e pelletterie, hanno registrato tassi di variazione negativi -sia delle U.L. che degli addetti- tali da modificare la posizione relativa della Toscana, sia nei confronti delle altre regioni dell’area NEC che dell’Italia nel suo complesso. In altre parole, “nel tessile la Toscana ha perso occupazione perché tutta l’Italia ha perso occupazione; [...] nelle calzature e nell’abbigliamento, invece, ha perso occupazione mentre l’Italia nel suo insieme manteneva i livelli iniziali” (Varaldo, Bellini, Bonaccorsi, 1997: 60). E’ dunque su questo sfondo che si innestano le analisi contenute in questo capitolo che è organizzato come segue. Nel primo paragrafo si commentano brevemente alcune caratteristiche di base delle imprese oggetto di indagine; nel secondo si analizza la configurazione assunta dal processo produttivo; si analizzano quindi i mercati di sbocco della produzione (par. 3) e la spesa pubblicitaria (par. 4) per passare, nel paragrafo 5, alla valutazione complessiva dei vantaggi competitivi del sistema moda toscano. Nel sesto paragrafo si analizzano i dati relativi alla domanda di lavoro; nei successivi il fabbisogno professionale e il fabbisogno formativo delle imprese toscane del sistema moda. Come si è visto più in dettaglio nel capitolo 2 il campione di 50 imprese con un totale di 1.260 addetti utilizzato per l’analisi della competitività è risultato composto per il 76% da imprese che si collocano al di sotto della soglia dimensionale dei 25 addetti. Il 34% delle imprese ha un fatturato che, nel 1996, non supera i 3 miliardi di lire e quasi la metà del campione è costituito da società di fatto. Le specificità da rilevare a livello settoriale riguardano soprattutto il fatto che le imprese della pelletteria e della maglieria risultano relativamente più concentrate delle altre nelle classi dimensionali minori, ma fanno rilevare una produttività per addetto generalmente più elevata. Nelle pelletterie e nella maglieria, infatti, è più alta che negli altri comparti la quota di imprese al di sotto dei 25 addetti, ma contemporaneamente più contenuta la quota di imprese che ha fatturato inferiore a 3 miliardi. Il fenomeno è probabilmente dovuto ad un maggior ricorso al decentramento produttivo (soprattutto nel caso delle pelletterie) e ad una maggiore meccanizzazione dei processi (nel caso delle maglierie). Tabella 12. Imprese toscane del campione competitività per quote di produzione standardizzata e settore (%) Fonte: elaborazioni Ciriec. Come si è ricordato l’analisi di domanda di lavoro, fabbisogno professionale e formativo delle imprese toscane del sistema moda è stata condotta su un campione di 68 imprese con un totale di 5.047 addetti al 31 dicembre 1996, scelte sulla base di criteri puramente qualitativi, privilegiando le imprese di dimensione maggiore, e quelle che sono state indicate come genericamente “interessanti” o “rappresentative” da testimoni privilegiati . La forma societaria prevalente è la società di capitali: le società per azioni e le società a responsabilità limitata rappresentano oltre il 70% delle imprese intervistate. La società per azioni è l’unica forma giuridica prevista in lieve crescita (+4,4%), a fronte di un quadro altrimenti totalmente stabile. L’età media delle imprese intervistate è alta -23 anni-, rispetto all’età media settoriale di appena 12 anni. La dimensione media è di 74,2 addetti contro i 5 della media regionale. Si tratta dunque, proprio per la modalità della selezione, di un campione di imprese spostato sulle imprese più grandi. Il fatturato medio del 1996 è stato di 20,490 miliardi; ed è sostanzialmente invariato a prezzi correnti rispetto al fatturato medio del 1995, e a quello previsto per il 1997. Le imprese con più di una unità locale sono il 25% del campione; mentre appartengono ad un gruppo nazionale o internazionale il 20,6%. Dalle risposte sembra di essere di fronte a un gruppo di imprese in rapida fase di innovazione, un risultato non del tutto in linea con le tendenze generali evidenziate nei paragrafi precedenti e che emergeranno nel corso di questo rapporto. Il 48,5% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver introdotto nel corso degli ultimi due anni innovazioni di processo e di prodotto; il 16,2% solo di prodotto; il 3% solo di processo. In complesso le imprese che non hanno modificato né prodotto né processo rappresenterebbero solo il 32,3% del campione. Meno diffuse le modificazioni organizzative, attuate dal 37% delle imprese. Organizzazione del processo produttivo Come è ben noto (e.g. ORML-Ciriec 1996a, 1996b), l’industria manifatturiera toscana annovera tra i propri principali punti di forza un elevatissimo grado di flessibilità produttiva, essenzialmente determinato dai rapporti di sub-fornitura che legano tra loro le imprese localizzate all’interno delle diverse realtà distrettuali e delle diverse aree sistema. Specularmente, alcune delle ricerche condotte sull’industria manifatturiera toscana evidenziano, a livello generale: (i) un basso livello di investimenti; (ii) una insoddisfacente propensione all’innovazione; (iii) una produttività del lavoro mediamente più bassa di quella dell’area NEC; (iv) l’esigua presenza di imprese medie in grado di configurarsi, instaurando rapporti a rete con i propri sub-fornitori, come elemento trainante dello sviluppo locale. Modelli di impresa L’analisi del decentramento produttivo all’interno del sistema moda è stata svolta con due obiettivi precisi: (i) definire la configurazione nella quale si attua il decentramento; (ii) individuare precisamente quali funzioni sono svolte all’interno o all’esterno delle imprese al fine di ricostruirne il fabbisogno professionale.
La distinzione tra imprese capofila e conto terzi che si adotta è basata sulla valutazione congiunta di alcuni indicatori. Si considera in primo luogo la quantità di produzione svolta in conto proprio/conto terzi, e si incrocia questo parametro fondamentale con la posizione assunta in un albero gerarchico di subfornitura, e con le fasi produttive svolte direttamente o esternalizzate dall’impresa. La sintesi di queste tre informazioni ha permesso di distinguere nel sistema moda nel suo complesso, ma anche in tutte le sue articolazioni settoriali, alcune strutture tipiche di impresa. Come accennato, la prima distinzione è relativa alla percentuale di produzione svolta in conto proprio ed in conto terzi. Data la varietà di strutture organizzative, si è ritenuto di definire imprese capofila quelle che hanno dichiarato di produrre almeno per il 70% in conto proprio. Alle imprese in conto terzi è stato quindi chiesto di indicare la propria posizione nel grafo riprodotto nella figura 4. Diagramma 4 Tipologie di impresa L’informazione che vi è riassunta permette di individuare (i) il livello gerarchico dell’impresa di subfornitura; (ii) se l’impresa subfornitrice lavora per uno o più committenti; (iii) se l’impresa subfornitrice si avvale a sua volta di un ulteriore livello di subfornitura. Si è quindi chiesto di rappresentare schematicamente le principali fasi di produzione del settore di appartenenza; di indicare per ogni fase di produzione la quota di produzione svolta all’interno o all’esterno dell’impresa; di indicare per ogni fase la figura professionale più importante. L’analisi incrociata delle risposte ottenute ai tre quesiti ha permesso di individuare per il sistema moda in Toscana cinque tipi di imprese rappresentative. Prima di arrivare a questo risultato si devono però considerare brevemente alcune evidenze quantitative e fare una breve digressione sulle fasi di produzione delle imprese del sistema moda. Tutte le imprese intervistate hanno risposto alla domanda, ad eccezione della parte relativa alla figura professionale. L’indicazione operativa ricavata da questa esperienza indica che si deve comunque modificare la formulazione delle domande, in particolare eliminando il riferimento alle figure professionali, e inserendo una indicazione di massima a priori delle fasi del ciclo produttivo. Le imprese intervistate sono risultate per il 63,2% capofila, e per il restante 36,8% subfornitrici di primo livello. Il fatto di non avere incontrato imprese subfornitrici di secondo livello è probabilmente dovuto al posizionamento di quelle aziende in fasce dimensionali inferiori a quella media (55,3 addetti) riscontrata tra le imprese subfornitrici. Pur in mancanza di evidenza statistica, è ragionevole ritenere che le imprese subfornitrici di secondo livello o inferiori abbiano dimensioni in termini di addetti e fatturato molto modeste. Tabella 13. Posizionamento delle imprese toscane del campione lavoro nel comparto Si noti che oltre il 90% delle imprese capofila si rivolge a ditte subfornitrici per quanto riguarda una o più fasi della produzione; quasi la metà delle imprese subfornitrici ha a sua volta imprese subfornitrici. Sembra dunque di poter concludere che le imprese del sistema moda in Toscana sono generalmente strutturate su più livelli di subfornitura. Tutte le imprese intervistate hanno una rappresentazione sostanzialmente corretta, e relativamente schematizzata delle fasi del ciclo produttivo relativo alla propria produzione. La ricostruzione delle fasi di lavorazione è avvenuta in prima istanza per gruppi. I risultati in gran parte omogenei ed in ogni caso confrontabili hanno permesso di mettere a punto tre tipologie di ciclo produttivo -per la produzione di maglieria e abbigliamento, di pelletterie, e di calzature- non molto dissimili tra loro -come illustrato nelle figure 1, 2 e 3-. In ognuna delle tipologie di ciclo produttivo si possono distinguere quattro gruppi di fasi: un insieme più o meno complesso di fasi relative alla progettazione; la campionatura; un insieme più o meno complesso di fasi relative alla produzione vera e propria; ed infine il controllo di qualità e il confezionamento del prodotto. Nel caso della maglieria e dell’abbigliamento gli intervistati hanno indicato esplicitamente anche le modalità di programmazione della produzione, ovvero la fase di raccolta ordini. D’altra parte nei grandi gruppi industriali toscani la raccolta ordini è estesa anche alle calzature e agli accessori. Non è qui necessario entrare nei dettagli relativi alle varie fasi; è invece interessante notare che la semplificazione in macro-fasi - nsiemi di fasi elementari- appena proposta permetta di individuare alcune regolarità che sembrano interessare le imprese del sistema moda. Sulla base di queste regolarità è possibile individuare quattro tipologie di imprese: Modello 1. In questa tipologia rientrano le imprese capofila che svolgono all’interno le sole fasi progettuali, il controllo di qualità e la campionatura; IRPET (1992: 63) aveva riscontrato solo debolissime evidenze di tale tipologia di impresa, in ogni caso concentrate in fasce dimensionali molto inferiori a quella in cui sono state rilevate dalla presente ricerca. Sembra che le percentuali siano stabili su questi livelli dal 1994; e che per il 1997 non si prevedano modificazioni. Sembra addirittura che i migliori risultati del gruppo delle subfornitrici siano da imputare per il 1995 soprattutto a questa tipologia di imprese. Si vedano anche i risultati di IRPET (1992: 63) dove le imprese contoterziste sono proporzionalmente più presenti nelle classi dimensionali inferiori. Modello 2. Vi sono comprese le imprese capofila integrate verticalmente, che svolgono all’interno tutte le macro-fasi del ciclo; Modello 3. Vi sono comprese imprese capofila che svolgono all’interno tutte le macro-fasi escluso il disegno che viene acquisito da società o consulenti esterni; Modello 4. Vi sono comprese le imprese subfornitrici che svolgono all’interno tutte le macro fasi - eventualmente avvalendosi di ulteriori subfornitori per fasi specifiche - eccetto quella di progettazione e controllo di qualità. Si tratta in sostanza di imprese complementari rispetto alle capofila del modello 1. A questi si aggiunge il modello 5 misto dove sono comprese le imprese che lavorano sia in conto-terzi che in conto proprio di cui si è detto in precedenza. Tabella 14. Distribuzione delle imprese toscane del campione lavoro per modello e settore Come mostra la tabella 3.2 la gran parte delle imprese è organizzata secondo i modelli 1 e 4: siamo di fronte cioè a capofila che svolgono le fasi di progettazione e controllo qualità, e subfornitrici che svolgono le fasi di produzione. Al primo modello appartengono, tra le altre, le ben note imprese del comparto della maglieria, dove è rilevante la figura dell’impannatore (Becattini 1997): queste imprese acquistano i filati, controllano i prodotti finiti e curano le spedizioni, affidando totalmente ad altri le fasi della tessitura e preparazione dei teli e quelle della confezione e della rifinitura. L’elevato ricorso al decentramento produttivo costituisce un indubbio punto di forza dell’industria manifatturiera toscana e assume una valenza ancora più strategica nell’ambito del sistema moda. La possibilità di ricorrere a sub-fornitori esterni consente infatti alle imprese di adeguarsi tempestivamente alle mutevoli condizioni della domanda e di evitare una crescita dimensionale che, proprio a causa della variabilità della domanda, potrebbe non rivelarsi una scelta efficiente. La rilevanza che, nell’organizzazione del processo produttivo, assume il ricorso a sub-fornitori esterni è peraltro sottolineata dal fatto che il 30% delle imprese del campione dichiara di avere incrementato nel corso dell’ultimo triennio e il 25% prevede di incrementarlo ulteriormente. Va rilevato, inoltre, che, nella maggioranza dei casi, i sub-fornitori sono localizzati nella stessa area di insediamento dell’impresa committente o, comunque, all’interno della stessa provincia o dei confini regionali. La vicinanza territoriale con i sub-fornitori ha evidentemente un impatto positivo sulla flessibilità dell’intero sistema e consente di ipotizzare che la localizzazione all’interno di aree sistema rappresenti ancora, per le imprese, una fonte importante di economie esterne. a) Naturalmente, non mancano casi in cui il tentativo di abbattere i costi di produzione spinge le imprese ad esternalizzare fasi produttive al di fuori della regione. Complessivamente, il 30% del campione affida lavorazioni, anche o esclusivamente, a sub-fornitori di altre regioni italiane (prevalentemente del sud) o stranieri . Tabella 15. Localizzazione dei principali sub-fornitori toscani del campione competitività* (% sul totale delle imprese non verticalmente integrate) Resta fuori una impresa che produce stivali in gomma. Mancano al totale le due imprese tessili e quelle indicate nelle due note precedenti. Tra le 4 imprese che svolgono internamente tutte le fasi produttive, soltanto una ha peculiarità di produzione che può spiegare la struttura organizzativa (produzione di cachemire). Sottolineiamo però che: a) solo 5 imprese si affidano completamente a sub-fornitori extra-regionali; b) il decentramento produttivo all’estero è fortemente disincentivato dal fatto che in questo modo verrebbe meno un requisito competitivo ritenuto indispensabile, cioè quello di poter “targare” i propri prodotti come “made in Italy”.
Fonte: elaborazioni Ciriec. * La domanda prevedeva risposte multiple A livello complessivo, va tuttavia rilevato che il decentramento produttivo comporta rapporti tra imprese committenti e sub-fornitori che sembrano ancora governati da leggi di mercato, piuttosto che di collaborazione. Nel senso che generalmente, i rapporti sono stabili nel tempo, ma quasi mai formalizzati e, di solito, non implicano forme di collaborazione, tra i diversi soggetti coinvolti, a livello di progettazione dei prodotti e/o di scelta e di acquisto delle materie prime, e così via (tabella 16); è scarsa, come già anticipato, la presenza di gruppi di imprese; come si è visto vengono decentrate le fasi produttive a minor valore aggiunto, e il decentramento di capacità sembra prevalere su quello di specialità. |
| Ricerca e Monitoraggio |