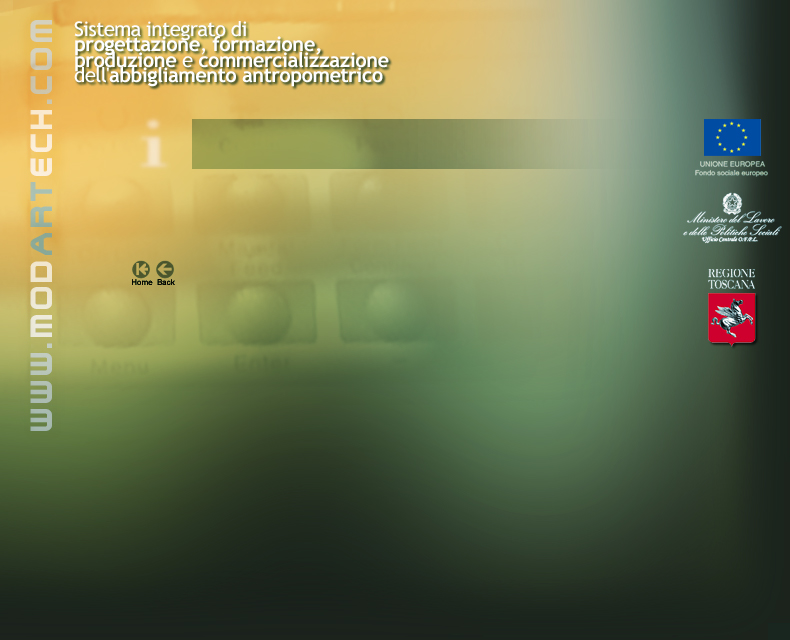
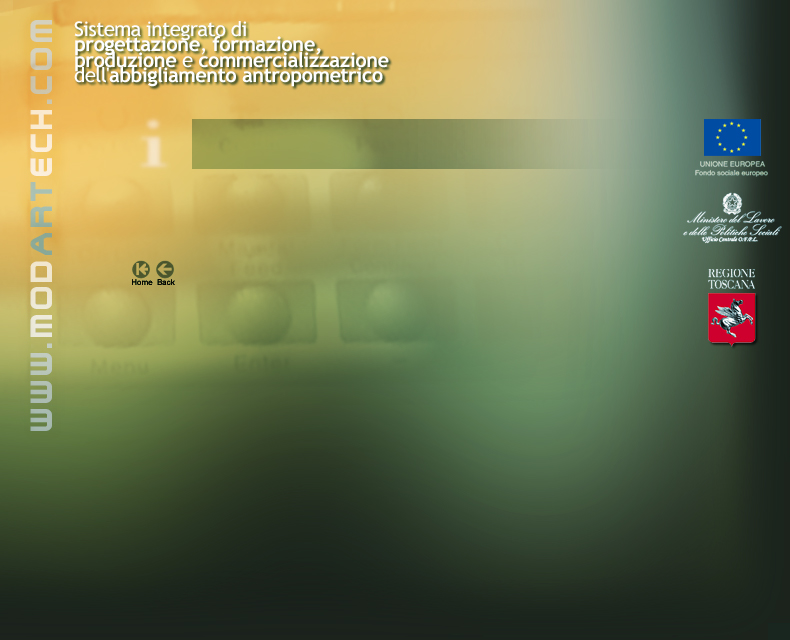 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|
Premessa
Le politiche regionali in un quadro di rapide trasformazioni strutturali, sollecitate dalla globalizzazione dei mercati, possono trarre giovamento dall'analisi di scenario. Scopo di tale analisi è diagnosticare e prevedere, per quanto possibile, opportunità e minacce allo sviluppo locale e all’occupazione derivanti dalle dinamiche di lungo periodo. Nel contesto toscano appare importante studiare l’insieme di settori del sistema moda, in quanto attività economiche in cui l’industria regionale è specializzata. Proprio per questo si tratta di settori già bene studiati e per i quali è disponibile una mole notevole di materiali di ricerca. La novità dell’approccio qui proposto risiede nel tentativo di integrare l’analisi dei fattori di competitività con quella della domanda di lavoro e del fabbisogno professionale espresso dalle imprese. Tale integrazione avviene affiancando un consolidato sistema di studio dei fattori di competitività alla metodologia di indagine che l’ORML ha utilizzato per l’analisi della domanda di lavoro delle imprese manifatturiere medio-grandi e del comparto della meccanica strumentale. La continuità metodologica con le precedenti ricerche dell’ORML ha permesso non solo di perfezionare ulteriormente i metodi di indagine, ma anche e soprattutto di fornire elementi conoscitivi che non sono presenti nella pur ampia letteratura esistente. Tali elementi conoscitivi potranno servire da riferimento e supporto di medio-lungo periodo per la programmazione delle politiche regionali nel campo della formazione professionale. Lo studio si propone una valutazione nel contesto nazionale e internazionale delle capacità competitive, della domanda di lavoro e del fabbisogno professionale dell’insieme delle imprese che costituiscono il sistema moda in Toscana. In particolare, gli obiettivi perseguiti sono: l’analisi del sistema competitivo; l’analisi della dinamica di medio periodo della domanda di lavoro e del fabbisogno professionale; l’esame comparativo del sistema moda –Lombardia, Ile de France- in altre aree ad elevata capacità competitiva, al fine di verificare se il sistema competitivo toscano punti su fattori in linea o tendenti a quelli delle aree forti o, viceversa, se ne differenzi; l’esame comparativo della domanda di lavoro e del fabbisogno professionale espressi dal sistema in Toscana, Lombardia, Ile de France, al fine di individuare le principali caratteristiche strutturali dei relativi mercati del lavoro. Il lavoro è organizzato come segue. Nel primo capitolo, è esposta la metodologia utilizzata per la rilevazione sul campo e per l’individuazione dei campioni di indagine. Nel secondo, vengono commentati alcuni dati aggregati relativi al sistema moda italiano. I successivi tre capitoli sono dedicati all’analisi degli scenari competitivi e della domanda di lavoro in Toscana, Lombardia e Ile de France. I principali elementi emersi dall’analisi comparata delle tre regioni sono ripresi in sintesi nel capitolo finale che contiene altresì alcune indicazioni per le politiche pubbliche della Regione Toscana. L’appendice infine contiene oltre ai questionari utilizzati per l'indagine sul campo, le elaborazioni che, per ragioni di leggibilità, si è preferito non inserire nel testo.
Note metodologiche Questo capitolo ha lo scopo di chiarire la metodologia e le tecniche di indagine adottate nella ricerca sul campo (par. 3), oltreché le scelte compiute in relazione alla definizione del campo di indagine (par. 1-2) e dei campioni di imprese (par. 4). I comparti del sistema moda La presente ricerca adotta una definizione restrittiva di imprese del sistema moda comprendente i seguenti gruppi della classificazione ISTAT 1991: 1760: fabbricazione di maglierie; 1770: fabbricazione di articoli in maglieria; 1810: confezione di vestiario in pelle; 1820: confezione di altri articoli di vestiario e accessori; 1830: preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia; 1920: fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria; 1930: fabbricazione di calzature. Sono cioè indagate tutte le imprese che producono o che svolgono fasi per la produzione del bene di consumo finale. Sono state invece escluse o analizzate indirettamente le imprese che producono beni intermedi; le industrie tessili - gruppi 17.1-17.5 - e le industrie conciarie - 19.1 -. La terminologia adottata nel corso del testo è sintetizzata nella tabella 1. La scelta è stata essenzialmente suggerita dalle diverse performance evolutive che i due distinti gruppi di comparti hanno registrato in Toscana, nel corso degli anni ’80 (Bigarelli, Brusco 1995). Con riferimento ai comparti che producono beni destinati al consumo finale, infatti, la posizione relativa della Toscana rispetto al resto d’Italia ha subito un consistente e costante declino. Nel caso, viceversa, dei comparti a monte, la Toscana ha perso occupati ed unità locali, ma ha sostanzialmente mantenuto inalterata la propria posizione relativa (Becattini 1997). Tabella 1. Gruppi di imprese secondo la classificazione ISTAT 1991 La decisione di concentrare l’analisi sui comparti a valle risponde quindi innanzitutto alla necessità di analizzare i settori più critici dell’intera filiera produttiva. Questa impostazione ci ha consentito inoltre di non complicare eccessivamente l’analisi prendendo in esame gruppi di comparti che presentano problematiche e strategie di crescita tra loro eterogenee, come appunto sarebbe avvenuto nel caso avessimo nei campioni di indagine sia imprese produttrici di beni finali che di beni intermedi. Specularmente, va sottolineato che il fatto di aver escluso dall’indagine i comparti a monte non inficia la significatività dei risultati ottenuti perché le interazioni tra i due gruppi di comparti e le eventuali sinergie che da queste derivano sono state indagate analizzando i rapporti delle imprese intervistate con i propri fornitori di materie prime e beni intermedi. Le aree di indagine Come anticipato, la ricerca sul campo è stata effettuata, oltre che in Toscana, in Lombardia e nell’Ile de France nell’intento di analizzare i punti di forza e di debolezza del sistema moda toscano, tenuto conto delle capacità competitive di altre aree ad elevata specializzazione produttiva nell’industria della moda. L’analisi del caso lombardo si giustifica alla luce di tre considerazioni: (i) l’elevata specializzazione produttiva della Lombardia nei comparti che compongono il sistema moda ed il conseguente ruolo che tale regione assume, in Italia, come elemento di naturale confronto per il sistema moda toscano; (ii) la diversa dinamica evolutiva registrata dal sistema moda lombardo nel corso degli anni ‘80, periodo in cui si assiste ad un ridimensionamento del peso dell’industria toscana della moda e, viceversa, ad una sostanziale stabilità di quello dell’industria lombarda rispetto al corrispondente aggregato nazionale (cosa che evidentemente stimola la curiosità di indagare sulle possibili diversità strutturali o delle strategie di crescita adottate dai due diversi sistemi moda); (iii) il fatto che sia Milano che Firenze abbiano un ruolo riconosciuto di vetrine della moda e che è interessante verificare il potenziale impatto positivo diretto o indiretto sui rispettivi sistemi produttivi locali. L’analisi del caso dell’Ile de France è sembrata di qualche interesse per effettuare un confronto fra il caso toscano e quello di un'area in cui sono compresenti una elevata concentrazione produttiva (50% della produzione francese), un effetto vetrina di livello internazionale, un sistema di rapporti fra imprese distributive e di produzione che si è spinto molto avanti sulla strada del decentramento nei paesi in via di sviluppo. Si tratta quindi per molti versi di un caso assai diverso sia da quello toscano che da quello lombardo, cui tuttavia è idealmente collegato dall'immagine che nel sistema moda globale hanno rispettivamente Parigi, Firenze e Milano. La metodologia di indagine L’ipotesi di fondo che ha guidato la ricerca è che sia necessario integrare l’analisi dei settori industriali, ed in particolare dei fattori di competitività, con l’analisi della domanda di lavoro e del fabbisogno professionale. Più esplicitamente: che sia impossibile analizzare le implicazioni di medio-lungo periodo che il sistema moda può produrre sul mercato del lavoro in assenza di ipotesi relative alla possibile dinamica evolutiva dello stesso sistema moda. Questa ipotesi è la naturale evoluzione della metodologia di indagine già sperimentata dal Ciriec per conto dell’ORML (ORML-Ciriec 1996a; 1996b) basata sull’idea che la domanda di lavoro e il fabbisogno professionale dichiarato dalle imprese sia una rappresentazione che non necessariamente riflette i comportamenti reali. I propositi dichiarati normalmente non corrispondono ai comportamenti abituali e a quelli previsti dalle imprese. I risultati dell’indagine sul campo devono essere adeguatamente interpretati perché sia possibile trarne indicazioni utili per l’azione di politica formativa delle agenzie pubbliche. A questo fine diventa essenziale considerare il quadro di riferimento strutturale, le dinamiche organizzative e tecnologiche delle imprese (ORML-Ciriec 1998; Sestito 1997). Lo studio della conformazione del sistema tecnico-produttivo e distributivo delle imprese del sistema moda è un ulteriore passo nel tentativo di mettere a punto una metodologia efficace per la rilevazione del fabbisogno professionale reale delle imprese. L’analisi, come già ricordato, si è sviluppata lungo due filoni paralleli di indagine: uno relativo alla competitività, l’altro riguardante la domanda di lavoro, il fabbisogno professionale e formativo. In relazione ad entrambi i temi la ricerca è stata condotta sostanzialmente attraverso interviste strutturate con risposte chiuse o parzialmente chiuse alle imprese; ed attraverso interviste aperte a testimoni privilegiati selezionati tra gli operatori locali - associazioni territoriali e di categoria, sindacalisti, ecc. - privilegiando coloro in grado di fornire informazioni di insieme sui tre sistemi moda analizzati. Al fine di vagliare i risultati preliminari delle ricerche sono stati organizzati due workshop a cui sono stati invitati operatori e studiosi dei settori oggetto d’analisi. Si è ritenuto opportuno condurre la ricerca almeno in parte su campioni diversi per evitare di sottoporre ad una stessa impresa un questionario unico eccessivamente oneroso, comprendente i quesiti necessari ai fini dell’analisi della competitività e della domanda di lavoro. Si sono messi a punto due differenti questionari con una parte comune, che sono stati sottoposti a campioni differenziati di imprese, costruiti, come vedremo, secondo gli stessi criteri. E’ opportuno sottolineare che nel questionario relativo al sistema competitivo l'enfasi è stata posta su aspetti qualitativi e sui giudizi espressi dalle imprese, mentre in quello sulla domanda di lavoro l’attenzione è stata posta su aspetti più immediatamente quantificabili Per l’analisi della competitività il questionario - riprodotto in appendice - è rivolto a rilevare informazioni relative a: caratteristiche strutturali; organizzazione produttiva; rapporti con i sub-fornitori di fase e con i fornitori di materie prime e semilavorati; innovazioni di prodotto e di processo introdotte; mercati di sbocco e organizzazione di vendita; spese pubblicitarie; fattori individuati quali principali punti di forza propri, dei concorrenti nazionali, di quelli esteri e del distretto di localizzazione. Alle stesse imprese sono state inoltre sottoposte alcune domande concernenti il fattore lavoro, i cui risultati, quando possibile, sono stati elaborati insieme a quelli derivanti dal questionario utilizzato per l’analisi della domanda di lavoro. L’analisi del caso parigino, considerato il contenuto numero di interviste previsto nel piano di lavoro, è stato effettuato esclusivamente tramite interviste a testimoni privilegiati, tra i quali sono stati inseriti anche alcuni imprenditori. Per quanto riguarda domanda di lavoro e fabbisogno professionale si è utilizzato un questionario - anch’esso riprodotto in appendice - che rappresenta una elaborazione e perfezionamento di ORML (1996a e 1996b). Esso è strutturato in 6 sezioni. La prima parte è relativa alle caratteristiche anagrafiche, organizzative ed economiche delle imprese, e comprende un gruppo di domande utili alla ricostruzione delle caratteristiche salienti dei prodotti, della tecnologia e dell’organizzazione, in particolare per quanto riguarda il ricorso ai servizi esterni e alla subfornitura. La seconda, terza e quarta sezione sono dedicate alla ricostruzione di stock e flussi occupazionali. Dopo aver fotografato la situazione occupazionale al 31 dicembre 1996 si ricostruiscono i principali flussi occupazionali occorsi nel recente passato (1 anno) e prevedibili nel futuro prossimo. |

| Ricerca e Monitoraggio |