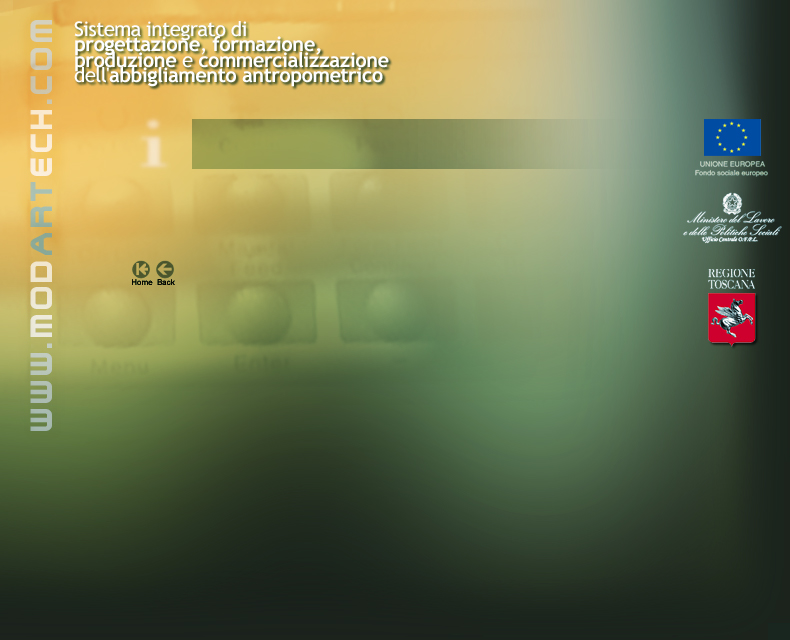
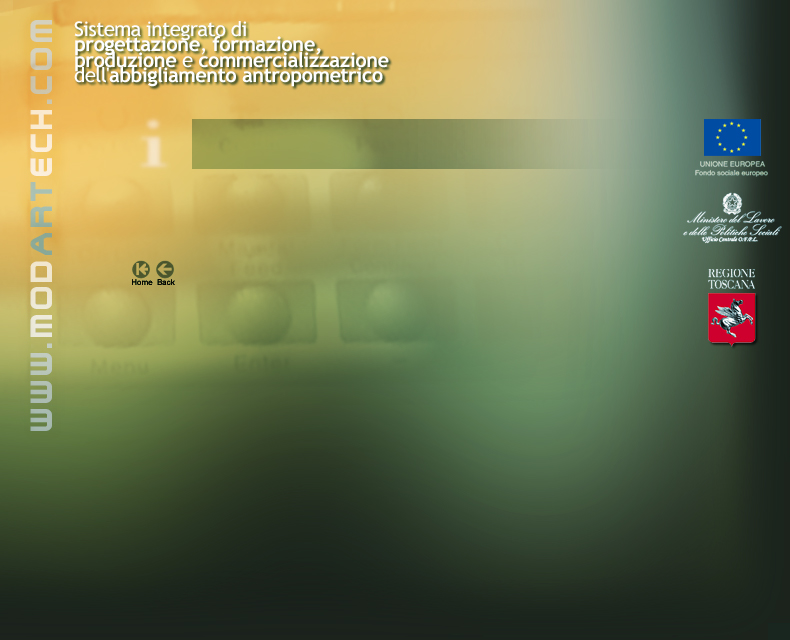 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|
Sintesi e indicazioni di policy
Il cosiddetto processo di globalizzazione delle economie ha provocato effetti profondi sull’industria della moda italiana ed europea. E’ anche vero, però, che un decennio di forte competizione a livello internazionale ha già determinato un processo selettivo da cui sono emersi come protagonisti sia dei competitori globali, tra cui alcune imprese italiane, sia dei veri e propri sistemi di piccola impresa. Proprio l’intensità delle trasformazioni in atto induce a tentare di ricostruire la dinamica odierna attraverso la descrizione di differenti modelli economico-produttivi, individuati nel corso dell’indagine, e l’analisi degli ambienti competitivi entro cui essi si misurano. Il punto di arrivo è l’individuazione di alcuni possibili ambiti di intervento strategico, al fine di contribuire ad orientare l’evoluzione dell’industria della moda toscana, tuttora fonte non secondaria di occupazione. Modelli competitivi L’analisi dei differenti insiemi di unità produttive che compongono l’industria della moda italiana e francese ha consentito di enucleare proprietà strutturali che differenziano tre aggregati economico-produttivi. Le proprietà si traducono in distinti modelli di funzionamento e profili competitivi, ma bisogna sottolineare che le differenze sono molto più nette tra l’industria francese e le altre due che fra queste ultime. Il punto di partenza della presente esposizione dei risultati conoscitivi acquisiti è la descrizione sintetica di tre sistemi produttivi. Nel sistema toscano un elevato grado di prossimità territoriale tra sub-fornitori e committenti è alla base di aree integrate di piccola impresa a livello locale (provinciale e sub-provinciale). Sono altresì individuabili cinque modelli di impresa (vedi paragrafo 4.2.1), all’interno di un sistema complessivo essenzialmente composto di due sub-sistemi: 1) un insieme di realtà gravitanti su un ristretto numero di imprese medio-grandi, che competono a livello internazionale; 2) un micro-universo delle piccole imprese produttrici di beni in conto proprio e in conto-terzi, che operano attraverso molteplici circuiti e flussi economico-mercantili. I due sub-sistemi hanno ottenuto nel periodo recente performances molto differenti: alti tassi di sviluppo il primo; nel complesso soddisfacenti -pur dopo un drastico processo selettivo- gli indicatori per il secondo. Una proprietà importante del sistema toscano è la elevata flessibilità produttiva, ottenuta grazie ad una scomposizione del ciclo in un ambito circoscritto. La distribuzione in una o più aree delimitate delle sequenze di fasi produttive ha permesso il tempestivo adattamento ad una domanda variabile di un modello operativo, incentrato sulla produzione di piccoli lotti di livello qualitativo medio-alto. Flessibilità ed adattamento si sono coniugati con particolari modalità di interrelazioni aziendali, in quanto la necessità di adeguamento alle esigenze del mercato hanno indotto una configurazione settoriale basata su relazioni stabili nel tempo, ma non estese a forme di profonda collaborazione in campo tecnico-produttivo. L’addensamento localizzato di aziende ha infatti favorito la diffusione di rapporti informali e mutevoli, mirati esclusivamente sul soddisfacimento di singole commesse. La ricerca di rapporti meno formalizzati, invece della creazione di gruppi formalizzati, ha però alimentato una dinamica tecnico-economica piuttosto vivace se, come risulta dall’indagine, le imprese stanno esercitando un apprezzabile sforzo innovativo (sviluppo di nuovi modelli/disegni, ricerca di nuovi materiali) in seguito alla pressione competitiva dei paesi a basso costo del lavoro. Un elemento da rimarcare, infine, è il livello elevato di produttività del lavoro, raggiunto in passato e previsto per il futuro da un tessuto produttivo con le indicate proprietà, a cui vanno aggiunte altre due caratteristiche: 1) carattere locale dell’elaborazione delle conoscenze e dei circuiti informativi tecnico-professionali; 2) consistente ricorso a servizi esterni alle imprese soprattutto per quanto riguarda i servizi amministrativi (finanziari e di gestione). Il sistema moda lombardo presenta alcune proprietà differenti da quelle del sistema toscano, a cui è peraltro accomunato da un alto ricorso al decentramento produttivo, al fine di fronteggiare la variabilità della domanda. L’elemento distintivo è però costituito dal minore radicamento territoriale della sequenza di fasi del ciclo economico-produttivo: la distribuzione su ampia scala (regionale, nazionale, estera) dei sub-fornitori e delle attività o funzioni ritenute utili si è unita alla creazione di forme di integrazione produttiva con unità sub-fornitrici soprattutto italiane, ma anche estere. All’ampliamento dell’estensione territoriale del ciclo corrisponde la ricerca di una maggiore integrazione strutturale ed operativa: emerge infatti una significativa estensione del ricorso a collaborazioni stabili tra imprese sulla base non di contratti, bensì di relazioni tecnico-produttive di ampia durata. Nell’industria della moda lombarda è stata inoltre rilevata una minore tendenza ad esternalizzare fasi produttive; ciò costituisce una conferma del fatto che ivi le imprese tendono ad essere meno disintegrate di quelle toscane. E’ quindi logico ritenere in Lombardia vi sia un differente mix di integrazione e flessibilità: ampia flessibilità territoriale nella scomposizione delle sequenze di fasi di produzione e integrazione tecnico-produttiva (rapporti di collaborazione tra imprese nelle fasi di livello elevato). Questo mix mostra, infine, una più marcata propensione all’innovazione tecnologica ed organizzativa. Abbiamo visto che in Toscana, invece, l’integrazione sistemica a livello di area è unita ad una estrema flessibilità del ciclo di produzione, incentrata su forme non stabili di relazioni interaziendali. Il mix toscano di integrazione flessibilità esprime inoltre una più modesta propensione all’innovazione tecnologica ed organizzativa. Il sistema moda francese si differenzia nettamente dagli altri due per una forte polarizzazione tra un nucleo ristretto di grandi case ed un esteso aggregato di unità produttive di dimensioni molto ridotte. Quest’apparato economico-produttivo, interessato negli ultimi anni da ampi processi di decentramento e delocalizzazione produttiva verso paesi con più basso costo del lavoro, presenta alcune proprietà peculiari: 1) scarsa propensione innovativa, tranne che nelle imprese maggiori ed in quelle che producono per stilisti famosi; 2) ridotta dimensione e semplicità organizzativa della maggior parte delle unità; 3) elevata standardizzazione della produzione; 4) progressivo impoverimento degli input di creatività nella tipologia prevalente del prodotto (pret à porter); 5) decremento qualitativo e quantitativo della manodopera impiegata. La configurazione complessiva dell’industria francese della moda appare particolarmente influenzata dalle modalità di organizzazione dell’apparato distributivo: il progressivo consolidamento di catene specializzate e della grande distribuzione ha evidentemente innescato la dinamica verso la specializzazione in produzioni destinate verso target di domanda interna a modesto contenuto qualitativo. Dalle precedenti riflessioni si può dedurre che il sistema moda francese è fondamentalmente caratterizzato da due fenomeni congiunti: 1) delocalizzazione del ciclo produttivo in senso stretto, fortemente ridotto a livello nazionale e distribuito in ambito internazionale; 2) sviluppo esteso dei meccanismi distributivi, fenomeno che possiamo definire superfetazione distributiva. Ambiente competitivo I due differenti mix di integrazione e flessibilità, da un lato, e le superfetazione distributiva, dall’altro, si traducono in corrispondenti tipologie di prodotto e di modalità competitive. Le imprese toscane e lombarde si collocano su fasce di mercato medio-alto, mentre la gran parte di quelle francesi si rivolgono a fasce di domanda di bassa qualità. Le unità toscane sono maggiormente proiettate verso i mercati esteri, dove maggiore è la concorrenza di prezzo, ma mostrano un minor grado di innovatività e risentono negativamente dell’assenza di una specializzazione dell’industria regionale nella produzione di beni capitali. Caratteristiche opposte mostra invece il sistema moda lombardo. Entrambi i micro-universi utilizzano, come meccanismi di proiezione sui mercati, canali distributivi basati su negozi indipendenti, con i quali sono intessute relazioni organizzative mediante un ampio apparato di agenti e rappresentanti plurimandatari. E’ superfluo precisare che alcune grandi unità della moda, veri e propri competitori globali, si caratterizzano evidentemente per la capacità di attuare strategie autonome e di impostare marketing mix verso differenti mercati. L’ampio aggregato di imprese, riconducibili ai 6 modelli descritti nel testo, opera invece nell’ambito di un esteso processo di frammentazione delle vendite, che esige uno sforzo organizzativo e commerciale piuttosto elevato, ma disperso in una miriade di unità attive. Lo scenario competitivo dipende, dunque, essenzialmente dal grado in cui il livello qualitativo del prodotto, sul mercato interno ed estero, isola per così dire dalle pressioni competitive dei paesi con bassi costi. Si può ritenere che la collocazione su fasce di mercato medio-basse implichi un inarrestabile processo di emarginazione produttiva, come dimostra l’esempio francese, dove la superfetazione distributiva è complementare all’impoverimento della qualità delle produzioni ed è al tempo stesso effetto della pressione concorrenziale esercitata da produttori dei paesi emergenti. In sintesi, quindi, nei tre sistemi della moda sono individuabili due tipologie competitive generali: mix di integrazione-flessibilità, da un lato, superfetazione distributiva, dall’altro. Le differenze interne al mix hanno comunque una base comune essenziale: esiste un core tecnico-produttivo, differentemente distribuito a livello territoriale, ma pur sempre sviluppato e progressivamente consolidato. Determinati fattori hanno favorito la capacità di competere delle unità appartenenti ai tre insiemi: qualità del prodotto, design, flessibilità produttiva, rapporto prezzo/qualità, gamma dell’offerta sono i punti di forza dell’industria toscana; oltre che per i precedenti fattori le imprese lombarde si distinguono per le innovazioni di prodotto e i tempi di consegna; l’industria francese eccelle soprattutto nel rinnovo rapidissimo dei prodotti e per i tempi molto stretti di consegna. Da queste proprietà fondamentali dipendono poi gli stili competitivi radicalmente diversi per tipologie di prodotte e ambiti concorrenziali in cui si verifica la proiezione verso la domanda. Le potenzialità dei modelli competitivi in uno scenario in evoluzione Sull’orizzonte futuro dell’industria della moda italiana e toscana sembrano profilarsi almeno tre possibili linee evolutive. Una può essere individuata nel modello francese, cioè nella riorganizzazione dell’apparato distributivo, con l’emergere di grandi soggetti in grado di razionalizzare i flussi e al tempo stesso di ridurre sia i costi di vendita sia i lag temporali nella consegna dei prodotti. Questo scenario ha però costi elevati in termini quantitativi e qualitativi, come dimostra appunto l’esempio dell’Ile di France, dove la rete distributiva ha avuto come pendant un depauperamento sostanziale della sfera produttiva. Una seconda linea di possibile evoluzione può essere individuata nell’ulteriore sviluppo ed estensione di aggregazioni semi-verticali tra imprese, in sostanza attraverso l’ulteriore consolidamento dei grandi gruppi, da un lato, e l’estensione dei modelli di integrazione descritti a proposito dell’industria lombarda, dall’altro. Questa prospettiva ha qualche fondamento, ma non appare in grado di ingenerare forti incrementi occupazionali, perché non esprime attualmente consistenti potenzialità espansive. In altri termini, soprattutto per quanto riguarda la Toscana, i pochi competitori globali esistenti non esercitano un’azione propulsiva verso l’intero universo regionale della moda. E’ più probabile, invece, che essi continuino ad essere un centro nevralgico di un sottoinsieme del sistema specialmente grazie al consolidamento di forme stabili di relazioni interaziendali con unità selezionate all’interno della gerarchia della sub-fornitura. In questa prospettiva le potenzialità di sviluppo, consistenti per il sub-sistema ma limitate per l’industria della moda nel suo complesso, si fondano su due presupposti fondamentali: 1) consolidamento e valorizzazione di livelli medio-alti di prodotto, ottenuti mediante la specializzazione artigianale delle fasi propriamente produttive, 2) elevata attitudine strategica nella proiezione sui mercati, basata su strutture commerciali e marketing mix in grado di favorire dinamiche di endogenizzazione della domanda. La terza linea evolutiva riguarda il secondo sub-sistema dell’industria toscana, composto di una miriade di unità distribuite su vari livelli di sub-fornitura e funzionanti secondo differenti modelli operativi . In questo micro-universo il cuore pulsante è l’ambito produttivo in senso stretto, mentre i flussi dei prodotti si riversano sui mercati attraverso il processo di frammentazione delle vendite al dettaglio. Siamo dunque di fronte ad unità con una accentuata specializzazione artigianale delle lavorazioni ed intrinseci limiti di imprenditorialità. Le realtà aziendali cui ci riferiamo perseguono sistematicamente la qualità, ritenuta condizione necessaria e sufficiente per incontrare la domanda interna ed estera. L’aspetto più delicato, su cui è opportuno riflettere, è però il seguente: il processo di frammentazione delle vendite significa di fatto una moltiplicazione dei circuiti economico-mercantili, con punti di incontro tra offerta (interna) e domanda (internazionale) dispersi sul territorio nazionale ed estero secondo logiche conoscibili solo nei termini generali, ad esempio: presenza di beni storici e monumentali; addensamenti di funzioni qualificate (aree e centri urbani); agglomerati insediativi con particolari target di clientela (quartieri residenziali), ecc. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’aggregato composito di punti vendita al dettaglio dei prodotti della moda esistenti nel centro storico di Firenze: un semplice (ed approssimato) calcolo dei flussi di turisti organizzati ed orientati verso i negozi significa attualmente una domanda potenziale fluttuante di grande dimensione quantitativa. Si tratta al momento di un mondo brulicante delle più disparate iniziative economiche (reti distributive, tour operators), che convergono nell’indirizzare domanda ed offerta, ma è importante tenere presente che esso è un mix di prodotti di nicchia, di segmenti di qualità medio-alta a consistente diffusione e di insiemi di beni meno pregiati. Le potenzialità future del secondo sub-sistema dell’industria toscana della moda dipendono in modo cruciale da quanto accadrà in tale micro-universo e dalle azioni intraprese per introdurre in esso elementi nuovi, alla luce di due punti basilari. E’ da escludere l’adozione del modello francese di configurazione settoriale ed appare irrinunciabile il mantenimento della specializzazione artigianale, ancorata a competenze e professionalità, che devono essere eventualmente rinnovate dal punto di vista tecnologico e generazionale. Emerge però un altro punto decisivo, dato dal fatto che, mentre i grandi gruppi sono in grado di elaborare ed attuare proprie strategie di proiezione sui mercati, il secondo sub-sistema di imprese deve compiere un salto qualitativo sul piano delle funzioni non direttamente produttive, se intende resistere a pressioni competitive sul prezzo (attualmente) e sulla qualità (un futuro sempre più vicino). Indicazioni per le politiche Per valutare gli ambiti per possibili interventi strategici è opportuno tenere presente, oltre al quadro evolutivo descritto nei paragrafi precedenti, le potenzialità occupazionali di tre aggregati economico-produttivi, esaminati nel corso dell’indagine. Il dato più significativo emerso è che nel periodo medio-lungo l’industria toscana della moda ha mostrato una capacità di creare occupazione chiaramente superiore a quella dell’industria lombarda e francese. E’ stato altresì argomentato come sia arduo ipotizzare che i tre sistemi moda possano rispondere alla sfida competitiva internazionale mediante la creazione di un volume significativo di nuovi posti di lavoro. Appare logico attendersi che i differenti modelli produttivi presentino specifiche modalità di reazione alla dinamica concorrenziale, a seconda delle proprie peculiarità strutturali. In questa prospettiva appare fondato ipotizzare che l’attitudine competitiva delle aree locali integrate (come nel caso della Toscana), si misuri attraverso particolari forme di flessibilità, espresse non tanto e non solo in variazioni dei volumi degli addetti delle imprese strutturate, quanto in un una dinamica più o meno intensa di genesi e chiusura di piccole aziende. Questo tipo di processo corrisponde alla razionalità adattativa che contraddistingue il sub-sistema non gravitante sui grandi gruppi. E’ anche probabile che l’industria lombarda, organizzata in forme più strutturate, persegua differenti strategie di risposta, mirate soprattutto su obiettivi di medio-lungo periodo più che aggiustamenti tempestivi alle commesse in arrivo. Un dato di fondo, su cui è opportuno richiamare l’attenzione ai fini di una riflessione in tema di policy, è la differente composizione qualitativa degli addetti tra l’industria toscana e lombarda. Nella prima prevalgono nettamente attività produttive e quindi la manodopera è in misura preponderante caratterizzata da bagagli professionali tecnico-pratici. Nella seconda è minore la rilevanza della sfera produttiva e -pur in relazione ad unità con specializzazione artigianale- è piuttosto significativo il fabbisogno di apporti e competenze essenziali per lo sviluppo di funzioni complementari rispetto alla produzione (vendita e marketing, ingegneria della produzione), ma strategiche in una prospettiva di competizione su nuove basi. Dall’analisi svolta risulta, pertanto, un quadro sufficientemente definito di livelli su cui esercitare azioni strategiche nella nostra regione. Essendo improponibile il modello francese per le regioni più volte espresse nei paragrafi precedenti, un primo punto da assumere è l’esigenza di salvaguardare e rafforzare il core tecnico-produttivo del settore a livello regionale; ciò significa attribuire centralità alla qualità delle lavorazioni, basata sullo sviluppo di lungo periodo della specializzazione artigianale. Di qui la grande importanza potenziale di interventi congiunti sul piano della formazione professionale e sul terreno fiscale-finanziario per l’incentivazione di posti di lavoro ad alo contenuto qualitativo, nel senso precedentemente indicato. Il binomio qualità-competitività non è però garantito adeguatamente senza la creazione di un nuovo trait d’union tra le molteplici unità appartenenti ai sub-sistemi. Intendiamo riferirci alla necessità di stimolare l’effettuazione di un salto qualitativo di imprenditorialità da parte di un segmento importante di imprese, che abbiamo definito capofila. Riteniamo infatti decisivo per l’evoluzione dell’industria toscana che queste ultime siano interessate da un processo di transizione da unità eminentemente produttive ad insiemi più complessi di funzioni. Il passaggio ad una visione e ad un modello di funzionamento come micro-sistemi appare essenziale per instaurare nuove modalità operative a due livelli: 1) nei rapporti con il mercato, per il quale non è più sufficiente produrre un bene ad alto valore aggiunto, ma occorre perseguire strategie sistematiche di proiezione mediante alleanze, joint ventures, accordi di collaborazione, ecc. 2) Nei rapporti con i produttori di materie prime, al fine di sviluppare sinergie di filiera (conceria/pelletteria/calzature, tessile-abbigliamento) integrando il know how accumulato in differenti segmenti economico-produttivi, in modo da rafforzare la base da cui proiettarsi nella competizione. Appare evidente come questo salto di imprenditorialità implichi inevitabilmente una crescita dimensionale, ma soprattutto lo sviluppo di modalità di funzionamento sistemico, cioè di modelli di funzionamento e gestionali maggiormente orientati alla ricerca di integrazioni di sistema attraverso forme di aggregazione semi-stabili (per progetti, strategie di presenza sui mercati, ecc.). Questa tesi porta immediatamente ad un terzo possibile livello di intervento strategico, ovvero lo sviluppo -anche per il tessuto di piccole imprese non legate ai grandi gruppi- di strumenti promozionali e di comunicazione, che consentano al sistema moda regionale di aggredire i mercati non più solo con prodotti di qualità, bensì con beni che, oltre ad essere di qualità elevata, siano anche di griffe. E’ opportuno sottolineare, infatti, che la domanda tende sempre più a polarizzarsi su due estremi: prodotti a basso prezzo e prodotti firmati. Gli ambiti indicati di policy dovrebbero infine trovare un elemento propulsore fondamentale nella dinamica innovativa per l’intero comparto. E’ auspicabile che la diffusione di innovazioni tra le imprese minori si espliciti secondo almeno tre direttrici: 1) sviluppo dell’industria locale di beni capitali; 2) interazioni sistematiche con i comparti a monte della filiera produttiva; 3) creazione di società specializzate nella realizzazione (con tecnologie innovative) di alcune fasi produttive ritenute particolarmente strategiche (ad esempio il taglio, lo sviluppo dei modelli, ecc.). E’ evidente, infine, che un aspetto cruciale per l’evoluzione del comparto a livello toscano è costituito dalle modalità di interazione tra le grandi unità produttive e le altre componenti: il successo delle prime è basato soprattutto sulla loro capacità di anticipazione strategica delle tendenze di mercato e sull’attitudine ad orientare la domanda con marketing mix globale, ma le loro performances dipendono anche dalla possibilità di avvalersi di un buffer di piccole imprese di produzione. Il punto di arrivo della nostra analisi è allora che la competitività del sistema moda toscano ed italiano si gioca quindi su rapporti quanto più possibile strutturati e interdipendenti tra questi due micro-universi, dal momento che può essere di tutta rilevanza il contributo della piccola impresa all’innovazione e alla differenziazione del prodotto. Bibliografia “Pelletteria di lusso, Firenze decolla”, Il sole24ore, 17/02/1998. AA.VV., Occupazione e ristrutturazioni industriali: il caso dei settori tessile e abbigliamento, Quaderni economia del lavoro, Milano, Angeli, 1978. Balestri, A., Cambiamento e politiche industriali nel distretto tessile di Prato, CNR – progetto finalizzato, struttura ed evoluzione dell’economia italiana, Roma, Angeli. Balloni, V., “Crisi e rinascimento dell’industria della moda in Italia”, L’Industria, 1, 1994: 141-162. Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia della Toscana nel 1995, Firenze, 1996. Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia della Toscana nel 1996, Firenze, 1997. Becattini, G., “Prato nel mondo che cambia (1954-1993)”, Storia di Prato, Firenze, Le Monnier, 1997: 465-600. Brusco, S., Bigarelli, D., “Struttura industriale e fabbisogni formativi nei settori della maglieria, delle confezioni e delle calzature in Italia. Un’analisi per regione”, Mimeo, 1995. Burresi, A., Fattori di cambiamento nella competizione internazionale ed orientamenti strategici per le aziende pratesi, Firenze, 1989. Cavalieri, A., L’internazionalizzazione del processo produttivo nei sistemi locali di piccola impresa in Toscana, Milano, Angeli, 1995. Falorni, A., Marinari, D., Indagine sulle imprese toscane del gruppo moda, Firenze, IRPET, 1992. Grau, F.M., Les Industries de l’habillement, Parigi, Press Universitaires de France, 1996. Grassi, M., Rapporto sulle imprese di capitale in Toscana, Firenze, IRPET, 1997. IRPET, Dove e come nasce il prodotto moda, Milano, Angeli, 1991. IRPET, Il sistema fieristico fiorentino della moda nell’economia locale e regionale, Firenze, IRPET, 1993. ISTAT, Classificazione delle attività economiche, Metodi e norme, serie C n. 11, Roma, 1991. ISTAT, Classificazione delle professioni, Metodi e norme, serie C n. 12, Roma, 1991. ISTAT, Indagine sull’innovazione tecnologica: anni 1990-92, Roma, 1995. Lucchini, A., Martini, A., “Il settore tessile: il distretto di Prato”, in Onida, F., Viesti, G., Falzoni, A. M. (a cura di), I distretti industriali: crisi o evoluzione?, EGEA S.p.A, Milano 1992. Mariotti, S., Efficienza e struttura economica: il caso tessile-abbigliamento, Milano, Angeli, 1982. Mosconi, G., Un mondo di calzature, Milano, Il sole 24 ore libri, 1997. Osservatorio nazionale del settore tessile, abbigliamento, calzature, Le caratteristiche strutturali del settore maglieria e confezione: i risultati della prima rilevazione dell’Osservatorio nazionale, SISSMA, CNA-Confartigianato, 1995. ORML, Crisi e ristrutturazione dell’industria toscana: le aree a declino industriale, Flashlavoro quaderni 27, Firenze, Regione Toscana, 1995. ORML-Ciriec, La domanda di lavoro nelle aziende manifatturiere medio-grandi della Toscana, Flashlavoro quaderni 42, Firenze, 1996. ORML-Ciriec, La domanda di lavoro nelle aziende del comparto della meccanica strumentale, Flashlavoro quaderni 43, Firenze, 1996. Reis, R., “L’industria italiana delle calzature”, Espansione, settembre 1992. Seri, G., “L’osservatorio della moda aretina”, Economia Aretina, 3, 1996:27-41. Sestito, P., Trento, S. “Tecnologia, organizzazione e domanda di lavoro”, in Ciocca, P (a cura di), Disoccupazione di fine secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1997: 157-202. Varaldo, R., Bellini, N., Bonaccorsi, A., Tendenze e vie di cambiamento dell’industria toscana, Milano, Franco Angeli, 1997. Zagnoli, P., Percorsi di diversificazione dei distretti industriali - Il caso di Prato, , Torino, Giappichelli, 1993 |

| Ricerca e Monitoraggio |